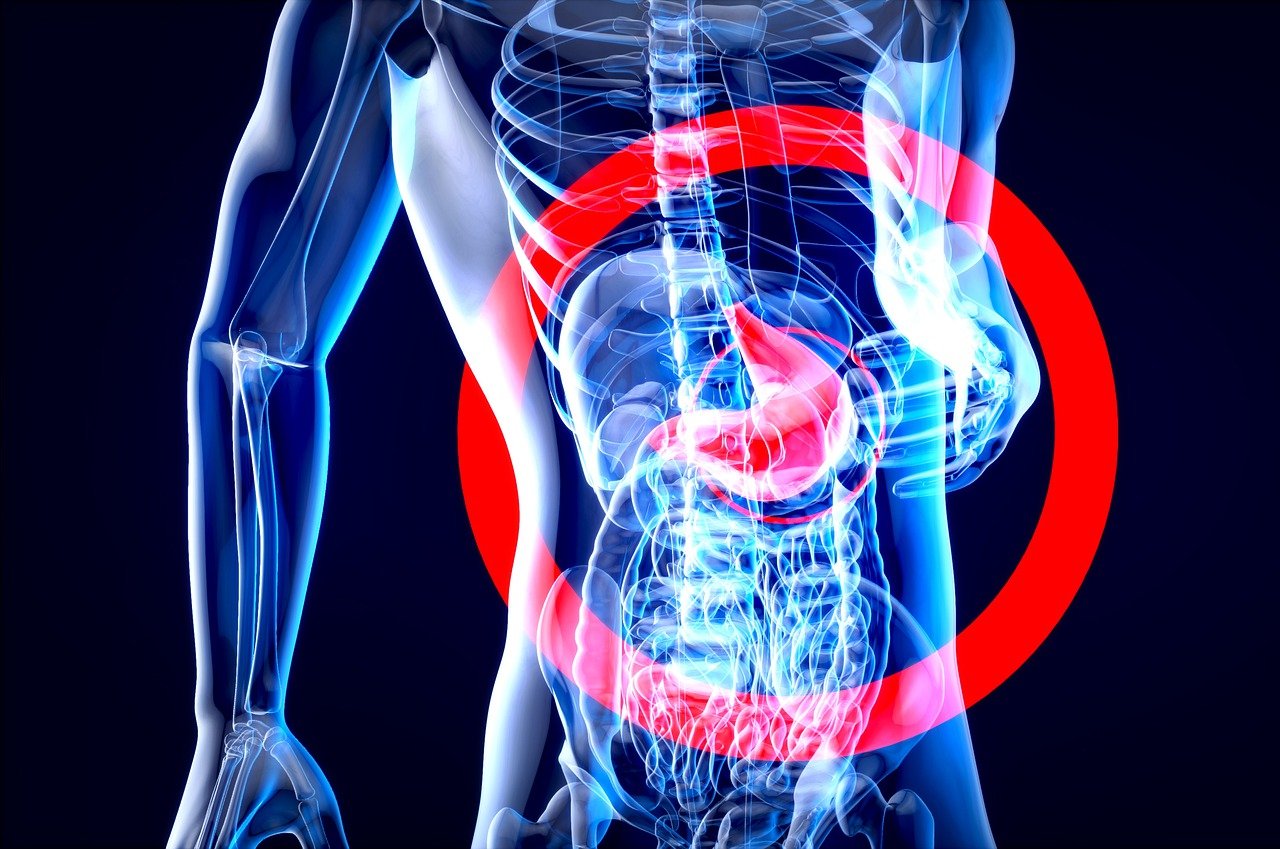Relazione bidirezionale tra Disturbi Alimentari e Disturbi Gastrointestinali
Inserito da Enrico Prosperi il 15/07/2024, nella categoria Disturbi Alimentari
Relazione bidirezionale tra Disturbi Alimentari e Disturbi Gastrointestinali
Negli ultimi anni c’è stato un netto incremento dei disturbi alimentari (attualmente definiti Disturbi della Nutrizione e Alimentazione) e le persone che ne soffrono presentano spesso anche sintomi gastrointestinali. C’è un crescente riconoscimento della relazione bidirezionale tra disturbi alimentari e disturbi gastrointestinali, ma se il ruolo che i disturbi alimentari hanno nell’insorgenza dei sintomi gastrointestinali è ben conosciuto, molto meno lo è quello dei disturbi gastrointestinali nello scatenamento o aggravamento dei disturbi alimentari.
Sempre più ricerche stanno evidenziando come le persone con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (Inflammatory Bowel Disease, IBD) e quelle con i cosiddetti “disturbi dell’interazione intestino-cervello” (sindrome dell’intestino irritabile, dispepsia funzionale, disturbo da reflusso gastro esofageo, ecc.) hanno maggiori rischi di sviluppare un disturbo alimentare.
Sappiamo come l’insieme dei microorganismi che popolano il nostro tratto gastrointestinale, microbiota, facilitano i processi digestivi, metabolici e la produzione di diverse sostanze come vitamine e neurotrasmettitori.
Il microbiota ha un ruolo essenziale nel cosiddetto asse intestino cervello, una sorta di autostrada che permette una comunicazione costante tra questi due apparati. Le restrizioni alimentari possono favorire una possibile malnutrizione con squilibrio di macro e micronutrienti, provocare un’alterazione del microbiota intestinale (disbiosi) e peggiorare i disturbi gastrointestinali preesistenti. La disbiosi sembra inoltre facilitare la produzione, dal parte di alcuni batteri, di metaboliti che causano una sazietà accelerata nell’AN e una mancata sazietà nella BN.
La restrizione calorica e la conseguente perdita di peso determina una riduzione della diversità alfa e di acidi grassi a catena corta (short-chain fatty acids SCFA): il decremento di quest’ultimi può determinare un aumento della permeabilità intestinale e facilitare uno stato infiammatorio che può arrivare ad interessare anche il cervello.
Le persone che soffrono di un disturbo gastrointestinale tendono a limitare la propria alimentazione e questo può dipendere da diversi fattori:
- i sintomi, come dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, stitichezza, rendono i cibi meno desiderabili;
- la paura degli effetti sull’appetito e sul peso di alcuni farmaci, come i corticosteroidi, con conseguente preoccupazione per la propria immagine del corpo;
- il legame che i pazienti, spesso erroneamente, riscontrano tra sintomi e specifici alimenti;
- le raccomandazioni dietetiche non sempre accompagnate da adeguate spiegazioni, supporti e tempistiche.
Alcuni pazienti potrebbero negare una spinta alla magrezza ma sviluppare un desiderio verso un’alimentazione sana e “pulita”. Se a questo si accompagna un’eccessiva preoccupazione per il cibo e per gli eventi sociali legati al cibo, programmazioni rigide durante la preparazione dei pasti e riduzione ponderale, potremmo sospettare la presenza di Anoressia Nervosa.
Un disturbo alimentare da sorvegliare è il Disturbo Evitante Restrittivo dell’Assunzione di Cibo (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID), caratterizzato dalla preoccupazione per le conseguenze negative nell’assumere determinati cibi, dall’evitamento di determinati alimenti, da perdita di peso, deficit nutrizionali e interferenza con il funzionamento sociale (DSM5). Un paziente con un disturbo gastrointestinale potrebbe imputare i sintomi a particolari alimenti ed eliminare interi gruppi alimentari. Oggi questo è particolarmente facilitato dalla mole di informazioni che chiunque può trovare sui social. Inoltre una riduzione dei sintomi potrebbe rinforzare l’idea che la causa sia in quel gruppo alimentare con conseguente suo evitamento. Anche una particolare dieta prescritta durante una fase critica (ad esempio la FODMAP) può indurre il paziente ad essere restio a reintrodurre alcuni alimenti per la paura della riacutizzazione dei sintomi.
Il ritardo della diagnosi di un disturbo alimentare in una persona con un disturbo gastrointestinale
Diversi sono i motivi per cui può essere ritardata la diagnosi o la cura di un disturbo alimentare in una persona che presenta un disturbo gastrointestinale:
- l’idea che un disturbo alimentare presenti necessariamente ed esclusivamente una riduzione del peso;
- la convinzione che i disturbi alimentari siano esclusivamente femminili;
- il credere che un disturbo alimentare sia una scelta dell’individuo (questo comporta una facile stigmatizzazione, considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il “fardello nascosto della malattia”)
- la mancanza di equipe interdisciplinari in grado di effettuare correttamente una diagnosi precoce.
Cosa fare per intercettare un possibile disturbo alimentare?
Durante la visita si può chiedere al paziente:
- il tipo di alimentazione nelle ultime settimane;
- se ha iniziato ad evitare particolari gruppi alimentari;
- se passa molto tempo nella pianificazione e preparazione dei pasti;
- se tende ad evitare situazioni sociali dove è presente il cibo, specie quello che non può direttamente controllare;
- se c’è stato un rapido calo ponderale;
- quale peso ritiene adeguato;
- quanto è preoccupato per la perdita di peso o per il suo possibile recupero;
- quanto esercizio fisico effettua e se si sente obbligato a farlo;
È fondamentale poter riconoscere precocemente un disturbo alimentare in una persona che presenta IBD o un disturbo dell’interazione intestino cervello, perché la sovrapposizione di sintomi può aggravare il quadro clinico fino ad una maggiore probabilità di mortalità. Per fornire interventi interdisciplinari è necessaria la presenza di diverse figure professionali adeguatamente formate, quali medici, psicoterapeuti, nutrizionisti. Gli interventi dovranno essere possibilmente strutturati, continui e in grado di mettere il paziente al centro del suo percorso. Questo è quanto richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per le malattie croniche, e prende il nome di Educazione Terapeutica del Paziente, intervento interdisciplinare che può aiutare il paziente non solo a migliorare il suo quadro clinico ma soprattutto la sua Qualità di Vita.
Dott. Enrico Prosperi
Medico Chirurgo Specialista in Psicologia Clinica
Presidente Società Italiana di Educazione Terapeutica
© 2024
Bibliografia
APA. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition). Washington, D.C.: American Psychiatric Association
Marano G, Mazza M, Lisci FM, Ciliberto M, Traversi G , Kotzalidis GD, De Berardis D, Laterza L, Sani G, Gasbarrini A, Gaetani E, 2023, The Microbiota–Gut–Brain Axis: Psychoneuroimmunological Insights, Nutrients 15(6), 1496
Paniz GR, Lebow J, Sim L, Lacy BE, Farraye FA, Werlang ME, 2022, Eating Disorders: Diagnosis and Management Considerations for the IBD Practice, Inflamm Bowel Dis Jun 3;28(6):936-946
Staller K, Abber SR, Murray HB, 2023, The intersection between eating disorders and gastrointestinal disorders: a narrative review and practical guide, Lancet Gastroenterol Hepatol Jun;8(6):565-578